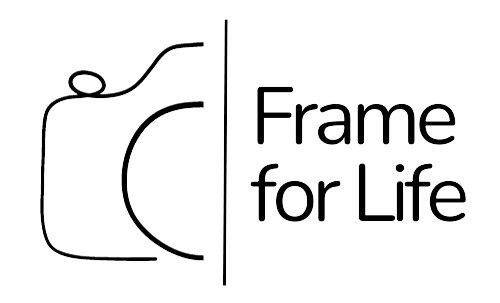È con grande piacere che Frame for Life intervista il fotoreporter Giulio D’Ercole per approfondire il suo modo di fare fotografia e la storia della sua lunga carriera a favore di tematiche sociali e umanitarie.
Giulio, grazie infinite per la disponibilità e il tempo che dedichi a Frame for Life oggi.
Conoscendo la tua professionalità, la tua esperienza in ambiti di comunicazione e fotografia a livello nazionale e internazionale, ci piacerebbe esplorare con te l’impatto e l’approccio del fotografo, il tuo punto di vista.

Cosa ti ha spinto a utilizzare la fotografia come strumento per il sociale e i diritti umani? Ti definisci un “Humanist photographer”. La tua formazione il tuo percorso di vita, ti hanno aiutato a dare alla fotografia un preciso significato? Cosa cerchi quando fotografi?
All’inizio della mia carriera ho lavorato prima in una radio privata e poi come organizzatore di una compagnia teatrale. Il mio vero cammino nell’ambito della comunicazione per immagini è iniziato nel 1988, quando sono stato assunto come producer televisivo da TeleMontecarlo (oggi La7). Il vero salto è stato però nel 1997, quando, trasferitomi a New York, ho ottenuto un contratto come Senior Producer con la Rai Corporation. È stato allora che ho lavorato alla realizzazione di importanti documentari storici, a parte le news e programmi di vario genere. Lasciata la RAI Corporation nel 2001, ho collaborato con una produzione italo-statunitense Rossellini Associati e Global Vision, occupandomi per loro di documentari sociali.
Queste esperienze mi hanno sicuramente offerto una formazione etica, professionale e personale che mi ha avvicinato al mondo del “sociale”. L’altro grande salto l’ho fatto poi, nel 2003, quando da New York mi sono trasferito in Kenya. Qui ho cominciato a lavorare per l’UNESCO, su un progetto di comunicazione implementato in Somalia che è durato circa due anni.
Contemporaneamente avevo aperto la mia casa di produzione, Canvas Africa Production, dedicata a documentari sui progetti umanitari. Da sempre fotografavo, ma fino a quel momento fotografavo come fotografano un po’ tutti, durante i viaggi o tra amici ma senza un reale approccio professionale. È stato proprio girando documentari in circa 14 paesi dell’Africa sub-Sahariana che è nato il mio amore per la fotografia. Ho quindi iniziato ad esprimermi attraverso la fotografia proprio facendo documentari per le Nazioni Unite e per le organizzazioni non governative sui loro progetti umanitari, recandomi nei luoghi più remoti e più poveri, nelle zone rurali più dimenticate.
Nel corso di dodici anni c’è stata una lenta ma progressiva e in qualche modo definitiva transizione dalle immagini in movimento all’immagine fissa.
L’opportunità, il lusso direi, di confrontarmi con realtà tanto diverse da quella conosciuta, attraverso esperienze professionali ed esistenziali straordinarie, mi hanno portato a questa attenzione verso l’umanità e a dare la priorità alla fotografia per raccontare le storie che incontravo.




La Narrazione visiva: Come scegli di narrare una storia attraverso le tue fotografie? Quali elementi consideri fondamentali?
L’aspetto umano, l’aspetto emotivo e empatico. Amo cercare, in qualche modo, di andare oltre il primo strato della superficie e della realtà che ci appare a prima vista, per andare a scavare quello che c’è dietro le cose, scoprire i vari spessori che il progetto che stai affrontando nasconde. A seconda dei casi, dei progetti e dei loro scopi, strutturo il racconto o attraverso una narrazione classica, con un inizio, uno svolgimento e una fine, o attraverso diverse foto singole, ognuna valida per sé stessa. Queste foto sono unite da un filo rosso emotivo che mette in luce quel tema senza necessariamente seguire la sequenza classica descritta prima.
Faccio un esempio attraverso l’ultima Mostra che ho potuto organizzare a giugno di quest’anno, a Spazio Europa, nel palazzo della Comunità Europea a Roma. Il titolo della Mostra è “Invisibili”, ed è dedicata alla solitudine degli anziani.
Per realizzarla ho utilizzato il mio archivio fotografico, alimentato nell’arco del tempo, dagli scatti effettuati nelle mie uscite fotografiche personali, scegliendo le foto che potessero raccontare questa condizione di solitudine. Ecco, qui non c’è un inizio, uno svolgimento e una fine ma ci sono come dei tableau vivant che identificano diverse situazioni in cui le persone si trovano isolate, nel silenzio, dimenticate, marginalizzate.
Sei tu fotografo che, partendo da un’idea forte, selezioni le immagini che vuoi raccontino la storia, unite da un filo conduttore significativo e inequivocabile.


Progetti significativi: Quali sono i progetti o le esperienze fotografiche più significative che hai realizzato? Ce ne sono in particolare per ONG o agenzie delle Nazioni Unite? che rapporto hai avuto con i beneficiari, con i soggetti fotografati?
È una domanda difficile perché in qualche modo ogni progetto è come un figlio, non puoi voler più bene a uno più che a un altro, quindi partendo dal presupposto che tutti i progetti hanno un loro posto dentro di me, certamente quello sugli anziani mi ha coinvolto molto anche perché ha al suo interno dei tratti personali: è infatti stato ispirato sia da una frase che mi disse mia madre quando aveva la mia età di adesso, cioè intorno ai sessant’anni, “quando invecchi non ti vede più nessuno”, sia dall’aver visto, capito e patito il senso di solitudine di mio padre. “Invisibili” è il progetto più recente e forse è anche per questo che è ancora caldo nelle emozioni.
Riguardo al mio rapporto con le persone che fotografo e vogliamo vedere altri progetti, per esempio quelli realizzati per il terzo settore, posso dirti che il mio presupposto, il punto di partenza è prima di tutto l’ascolto: mettersi sullo stesso livello, cercare di tirar fuori delle cose senza “strapparle” ma in maniera quanto più gentile possibile e con quanto più rispetto possibile. Se stai fotografando un bambino non puoi fotografarlo dall’alto in basso, bisogna ricordarsi di mettersi sempre sulla stessa linea del soggetto, questo, credo sia fondamentale, ed è il primo passo verso un senso di grande rispetto.
È difficile a volte fare i conti con il senso di rispetto, quando vuoi portare a casa l’immagine per dimostrare un fatto, per fare emergere una denuncia o per supportare campagne di awareness. Una volta ero in Somalia con una mia amica e collega giornalista, la bravissima Beatrice Spadaccini, e stavamo facendo un lavoro insieme nei campi profughi. Lei stava intervistando un gruppo di donne e ad un certo punto arriva una ragazza somala con un bambino magrissimo in braccio, con evidenti segni di fame e malattia. La mia amica rimase molto molto colpita perché ovviamente il bambino stava molto male e cominciò a dirmi “ Giulio, ma vedi …ma vedi Giulio, ma vedi..” io stavo cercando di fotografarlo perché a quel punto è importante fotografare, quella, in quel momento è la tua missione, raccontare, e io le risposi “no, non vedo”. Dovevo difendere quello che stavo facendo. Questo in qualche modo è il paradosso della fotografia in determinati momenti. Non è vero che non vedi, stai vedendo eccome, ma la macchina ti fa da filtro e allo stesso tempo ti aiuta a vedere. Devi cercare di lavorare in maniera tale da dare quanto più rispetto possibile al tuo soggetto, ma DEVI raccontare quella storia perché sei lì proprio per raccontarla al meglio possibile, per mostrare al mondo cosa accade.

Impatto: Ecco questa risposta aiuta ad affrontare il prossimo tema, la fotografia come denuncia sociale, come sensibilizzazione, come strumento per emozionare e far aprire gli occhi su alcune realtà: hai mai visto il tuo lavoro avere un impatto concreto sulle comunità o sulle problematiche che documenti? Puoi condividere qualche esempio?
Onestamente io non ti so rispondere con dei dati alla mano, nel senso che quando lavoravo per le Nazioni Unite o per le ONG il mio lavoro che fosse il documentario o che fossero le foto certamente venivano effettivamente utilizzati sia come strumenti di awareness che di fundraising. Sicuramente hanno acceso l’attenzione ed hanno aiutato negli scopi preposti, ma non ti so quantificare i risultati in termini economici o di “audience”.
Certo basta pensare ai grandi esempi della storia della fotografia di reportage, quelle fotografie che hanno fatto la storia: dalla bambina vietnamita che fugge nuda bruciata dalle bombe al napalm in Vietnam, o il monaco buddista in fiamme, il ragazzo cinese di fronte al carro armato a piazza Tienanmen, il volto della ragazza della ragazza afghana di Steve Mccurry. Queste immagini hanno avuto un impatto enorme, tuttavia appartengono a un mondo in cui c’era poca “fotografia”. Oggi siamo sommersi da fotografie di tutti i generi e credo che oggi sia molto più difficile avere un impatto con la fotografia singola.
Oggi credo si debba educare alla fotografia come mezzo di comunicazione in modo che quel mezzo di comunicazione abbia un impatto. L’immagine che scattiamo deve distinguersi dalla moltitudine delle immagini che girano sui social e che mostrano di tutto. La Fotografia con la F maiuscola, ci deve portare a momenti di riflessione, a spazi condivisi di attenzione.
Sfide: Quali sono le principali sfide che affronti quando lavori in contesti delicati o di crisi?
Prima di tutto la possibilità di accedere a certe tematiche perché intorno a certe cose vengono messi dei cordoni, anche da un punto di vista di sicurezza. Intendo che in determinate situazioni non ti puoi muovere liberamente e quindi sei condizionato nel tuo lavoro. Ricordo una volta che ero in Kenya in un campo profughi dovevo fotografare dei giovani somali ma il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite mi impediva praticamente di entrare e arrivare a loro. Ho pensato “beh mi hanno assunto per fare questo lavoro e in qualche modo lo devo fare”, per cui ho lasciato la project officer dell’organizzazione per cui stavo lavorando e dopo aver parlato con i ragazzi profughi, sono andato con loro dentro il campo. Forse non era proprio la scelta più sicura, però, invece, è risultata quella migliore: i ragazzi vedendo la mia buona volontà, vedendo la mia onestà, vedendo la mia voglia di sentire il loro punto di vista, mi hanno accolto, permettendomi di fotografare nelle loro case, mentre si riunivano e dialogavano. E’ stata una delle esperienze più belle e più indimenticabili che ho, anche a livello umano strettamente personale. E’ chiaro però che non sempre si può fare, a volte la situazione è talmente pericolosa che ci si deve fermare.
Un’altra sfida è quella con sé stessi. Bisogna seguire un po’ anche il proprio sentire, il richiamo dell’unicità.
Una volta ero in Uganda sempre per un servizio fotografico, stavamo andando verso il nord e ci siamo dovuti fermare in un villaggio al bordo di una strada sterrata. Avevamo affittato camere in una sorta di albergo che confinava con un bar, forse una specie di discoteca locale, che suonato musica ad altissimo volume tutta la notte, impedendomi di dormire. Alla fine, saranno state le 5:30 del mattino, sono uscito. Non c’era nessuno in giro a quell’ora e mi sono incamminato con la macchina fotografica al di là del villaggio, praticamente nel bush, e a un certo punto ho sentito dei canti. Fu come seguire la musica del “pifferaio magico”, fino a quando quella musica mi ha portato ad una scuola per ragazze. Loro si stavano preparando per la giornata, chi con le preghiere mattutine, chi con altre faccende, tra cui andare a prendere l’acqua al pozzo. Rimanendo in silenzio, ho salutato con gli occhi e con gli occhi ho chiesto il permesso di fotografare. Loro, silenziosamente hanno acconsentito. L’emozione di quel momento è ancora palpabile, oltre al fatto che ho realizzato foto bellissime in controluce prima dell’alba, con il sole che stava sorgendo dietro alla vallata e al pozzo.
Mi basta il ricordo di quell’esperienza vissuta per essere felice.

Etica: Quali principi etici segui quando fotografi persone in situazioni vulnerabili?
Nelle tue interviste ci tieni a sottolineare che con le foto vuoi far emergere dignità, bellezza, amore, vita, empatia, speranza..? anche nelle situazioni più drammatiche, riesci a vedere la bellezza, la trovi sempre?
Quando inizi a fare fotografia, cominci a fotografare le cose che ti colpiscono di più, per esempio i poveri e i senza tetto sdraiati per terra, eccetera. Ecco quella è una cosa che io non faccio assolutamente più, ormai da decenni, nel senso che non fotografo il vulnerabile che non mi può rispondere, il vulnerabile su cui io impongo la mia forza e il mio potere di fotografo.
Prima di tutto il rispetto. Inoltre cerco quanto più possibile di trovare la bellezza o addirittura se possibile la gioia. Sempre la dignità.
Ho vissuto in Kenya 12 anni, ovviamente le situazioni erano tutt’altro che brillanti, una volta mi trovavo in una zona di periferia disastrata, una baracca di lamiere, in cui viveva una donna gravemente ammalata di Aids. Io dovevo fotografarla …certo la situazione era davvero triste, non è che metti i fiocchetti rosa intorno alle cose per renderle più belle, ma quello che puoi fare è trattare le persone da esseri umani. Certo, la foto sarà dura, però tu sai bene come ti sei posto, il rapporto umano che hai creato con quella persona, l’averci parlato e magari averla fatta anche sorridere. L’importante è entrare nei discorsi più profondi e più dolorosi con il rispetto per la dignità altrui.



Evoluzione del ruolo: Come pensi che il ruolo della fotografia nel campo dei diritti umani e della cooperazione sia cambiato negli ultimi anni?
Non so quanto sia cambiato, sicuramente sono cambiati in mezzi tecnologici e le vie di comunicazione per veicolare la fotografia verso il pubblico.
Nell’era digitale puoi riuscire ad avere una vastissima penetrazione, ma allo stesso tempo i messaggi e le foto portatrici di quei messaggi rischiano di essere soffocati dalle quantità abnorme di immagini da cui siamo quotidianamente e continuamente bombardati.
Non è un discorso semplice, se pensiamo alla fotografia come mezzo per aumentare la consapevolezza su certi argomenti, dobbiamo riflettere su che tipo di campagna vogliamo realizzare, se di sensibilizzazione o di raccolta fondi, per esempio, e in base al nostro obbiettivo dobbiamo identificare i canali più opportuni da utilizzare.
Ovvero dobbiamo pensare al nostro Target, se pubblichi un servizio su Internazionale o su La Repubblica avrai un impatto diverso rispetto a quello che avresti utilizzando i social media più dedicati alle giovani generazioni.
Oggi è fondamentale chiedersi quante persone leggono o approfondiscono davvero una tematica e su che strumenti lo fanno. Dobbiamo interrogarci se attualmente non sia più efficace impostare la comunicazione in modalità veloce, con poche immagini che colpiscono fortemente a livello emotivo. Dobbiamo capire, sapere e scegliere cosa vogliamo ottenere, e anche su questo i dibattiti di etica su come vengono svolte le campagne non si contano più.
Qual è il messaggio principale che speri di trasmettere attraverso il tuo lavoro? E quali progetti futuri hai in mente che continueranno a connettere la fotografia con temi sociali e di giustizia?
Ho in mente un progetto molto “personale” legato la tema dell’inclusione, della convivenza e della pace, da una prospettiva inusuale. Da circa due anni fotografo all’interno della Basilica di San Pietro a Roma, giocando molto con le luci e con le architetture, ma usando il genere fotografico della Street photography. Osservo le persone all’interno della Basilica, quello che fanno, come si muovono, le emozioni che vivono. La chiesa di San Pietro è il luogo della religiosità cattolica per eccellenza, eppure in questo lugo si uniscono il Sacro e il Profano, se non altro perché ci passano milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.
È quindi un luogo in grado di unire le diversità.
Il titolo del libro che vorrei pubblicare è “The Crossroad”, proprio nel senso di un racconto di un luogo la cui essenza è quella di essere un crocevia. Un punto in cui l’umanità nella sua grande diversità si incontra e convive.
Vorrei poter dare un messaggio contro l’alto livello di conflittualità oggi presente nel mondo.
Nei miei progetti cerco sempre di fotografare l’essere umano.
In questo mi ispiro molto a George Simenon che, in ogni suo libro, attraverso una narrazione semplice e precisissima, dipinge i suoi personaggi attraverso un’analisi profonda, sottile e fortemente empatica. Nei suoi romanzi Simenon svela ciò che si nasconde dietro la superfice: la storia e la vita che li portano ad essere quello che sono e a fare ciò che fanno. Ecco, con le mie fotografie io vorrei immortalare l’essenza di ciascuno, ognuno con il proprio vissuto ed ognuno come parte di un mondo.



Giulio l’ultima domanda è per i giovani fotografi che si avvicinano alla professione, che soprattutto vogliono approfondire la professione del fotografo in ambito sociale o umanitario, magari in collaborazione con enti del terzo settore. Quale consiglio ti senti di dare alle giovani generazioni?
Innanzitutto consiglio di studiare fotografia e comprendere a fondo la tecnica e attraverso a tecnica le potenzialità espressive del mezzo fotografico per raccontare delle storie.
Cartier Bresson, l’hanno citato in molti, diceva che per fare una buona fotografia bisogna allineare occhio, cuore e mente, dove la mente è anche la tua capacità di usare tecnicamente lo strumento. Sembra un’ovvietà, ma imparare a usare bene la macchina, è fondamentale. Penso sia necessario ribadirlo, soprattutto in questi tempi di enorme produzione di immagini scattate “al volo” e senza pensare.
Quale che sia la voce che tu hai, quella voce la devi esprimere bene in maniera tecnicamente valida ed efficace. Certamente devi anche fotografare molto, esercitarti, sbagliare, imparare dai tuoi scatti, dagli errori e dai tuoi successi.
Consiglio anche di affiancare studi fotografici o colleghi di esperienza per apprendere il più possibile da loro. Dopo si può iniziare a proporsi alle organizzazioni non governative che potrebbero aver bisogno delle tue foto per raccontare il loro lavoro. Per finire, bisogna sviluppare un proprio linguaggio, non adeguarsi allo stereotipo non adeguarsi al pensiero unico. Se si vuole essere un fotografo in grado di comunicare e raccontare storie, si deve avere una propria visione e un proprio modo di esprimerla.






Intervista a cura di Silvia Superbi, presidente di Frame for life.